Padre Nostro
La cancellazione dello Gnosticismo Cattolico
1. La Guerra della Chiesa allo gnosticismo cristiano

Se esiste una corrente gnostica all'interno della Chiesa Cattolica, oggi si sentirà sicuramente più povera.
Che lo gnosticismo sia la corrente filosofica più avversata dal Cattolicesimo Romano nel corso dei secoli è un fatto. Lo dimostrano le posizioni prese nei confronti delle dottrine gnostiche che si sono susseguite nel tempo in tutta l'area del mediterraneo, tutte condannate come eretiche e, molte, affogate nel sangue.
Quanto, però, accaduto nel silenzio assordante dell'ignoranza filosofica collettiva che permea i tempi moderni, è forse l'attacco più diretto allo Gnosticismo e ai movimenti antisecolari che la Chiesa di Roma abbia mosso da molto tempo.
E' bastato sostituire una semplice frase all'interno di una preghiera.
Quel "Non ci abbandonare alla tentazione" al posto del "Non ci indurre in tentazione" che ha attraversato i secoli, sembra un nulla, ma nasconde un messaggio deflagrante e pericoloso al tempo stesso.
Partiamo dall'inizio, però.
2. Il Padre Nostro come fondamento della dottrina Cristiana
Come mai quest'importanza per una semplice parola ?
Semplice: per i Cristiani il Padre Nostro e' il fondamento della dottrina, in quanto si tratta di una preghiera "insegnata" direttamente da Gesù e riportata sui Vangeli di Luca e Marco.
Le regole e i principi contenuti in essa, pertanto, sono ritenuti dai fedeli e dalla Chiesa diretta promanazione divina.
Modificare uno di questi messaggi, quindi, vuol dire modificare la dottrina generale Cristiana.
Nello specifico il messaggio "non ci indurre in tentazione" era stato oggetto, nei secoli, di numerose e differenti interpretazioni.
Se, infatti, è Dio ad indurre in tentazione l'uomo, esso non è buono in senso assoluto. Ma non lo è non tanto perché mette l'uomo alla prova, ma perché è in grado di creare il male e, quindi, non è bene assoluto.
Questo non sarebbe affatto in contrasto con una divinità unica da cui tutto promana, ma lo sarebbe con una divinità buona, da cui promana solo il bene.
Eppure questo sarebbe un grosso problema a livello di unità della divinità, in quanto un male esterno ad essa e in contrasto con essa, sarebbe in grado di minare l'assolutezza divina ponendola in contrasto con un'altra forza, se non equivalente ed opposta, perlomeno di forza e tipo equiparabile.
Il Cattolicesimo ha cercato di spiegare questo concetto giustificandolo con la corruzione del bene da parte di Satana. Dio, in quanto bene assoluto, crea il bene e il maligno corrompe il bene, trasformandolo in male.
Il discorso è certamente molto più complesso, ma semplifichiamolo per giungere ad una conclusione: se il diavolo può corrompere l'Opera di Dio, allora la forza del diavolo è, se non maggiore, perlomeno equiparabile a quella di Dio.
Stiamo entrando in un territorio spinoso dove molti si sono addentrati prima di noi, con competenze e conoscenze maggiori delle nostre e creando sofismi giustificatori che hanno generato dispute da cui sono nate guerre, persecuzioni, religioni e culture.
3. Il dualismo di Dio
Eppure esiste una spiegazione che mette tutti d'accordo: Dio non è né buono né cattivo, in quanto il bene e il male sono soggettivi e dipendono dalle scelte dell'uomo. Dio ha creato entrambi e ha messo l'uomo nelle condizioni di scegliere liberamente e, quindi, se l'uomo sbaglia è solo colpa sua. Questo concorderebbe con la visione del Dio che crea Lucifero e poi lo scaccia, mandandolo sulla Terra. Crea un luogo protetto, nel quale da a Lucifero la possibilità di corrompere la sua opera, in modo da mettere alla prova gli esseri umani e permettergli di scegliere.
Che Satana, identificato con Lucifero, sia il signore di questo mondo lo dice la stessa Bibbia:
"...nei quali il dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono…" (2 Corinzi 4:4);
"...secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza,…" (Efesini 2:2);
"...Ora è il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo." (Giovanni 12:31);
"Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio,…" (Colossesi 1:13);
"… e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo, che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà." (2 Timoteo, 2:26);
"Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno." (1 Giovanni, 5:19)
Tutti questi brani parlano dell'umanità soggiogata da Satana e liberata da Gesù per la capacità donata di saper discernere cosa è giusto da cosa non lo è e sapere, quindi, quali scelte compiere.
Allegoricamente la figura di un Dio che fornisce gli strumenti per non usare la libertà che abbiamo a danno di altri è perfetta. Ma crea un problema irrisolvibile: se anche il male promana da Dio e l'uomo ha libertà di scelta senza che vi possa essere intercessione divina, come si giustifica la figura del Papa ?
Gesù non sbagliava perché era Dio, ma il Papa era ed è un uomo, quindi fallibile e, quindi, viene meno anche il dogma dell'infallibilità papale, che guida la Chiesa Cattolica dal 1870, ma che la permeava anche prima.
Se il Papa sbaglia, però, come la mettiamo con tutto ciò che ne deriva in ambito teologico e filosofico ?
La mettiamo malissimo: occorre tamponare.
Dio è bene e il Papa, essendo il suo emissario in Terra, è guidato da lui e non sbaglia.
Ma se Dio non è solo bene ?
Se Dio ci lascia liberi e non intercede ?
Se Dio crea anche il male e, quindi, ci induce in tentazione ?
Allora potrebbe farlo anche suggerendo al Pontefice o ai suoi ministri azioni nefaste.
Quindi Dio non ci può indurre in tentazione.
Solo il Demonio può e, quindi, Dio non deve abbandonarci a questa tentazione.
Ecco un ulteriore rafforzamento, perché se può non abbandonarci, allora può intervenire.
Se noi lo seguiamo e siamo benvoluti da lui, lui interviene.
Una semplice parolina cambia il mondo.
Ma come siamo arrivati a questo cambiamento epocale dopo secoli, senza che nessuno dica nulla.
Lasciamo perdere il discorso filosofico, che oggi è per pochi eletti, parliamo di quello tecnico scientifico, quindi linguistico.
4a. Evoluzione linguistica: aramaico

Qualcuno ha fatto notare l'assoluta inversione di rotta, ingiustificabile in un mondo che, per quasi duemila anni, ha sezionato ogni pensiero e lo ha rielaborato a proprio uso.
La giustificazione è nel fatto che il testo aramaico originale è stato tradotto in maniera errata in greco e noi ci siamo trascinati questo errore per secoli.
A prescindere dalla credibilità che può avere una giustificazione così puerile (chi ne ha tratto il testo greco lo ha fatto in un periodo coevo all'esistenza della lingua aramaica, quindi aveva, certamente, più strumenti di noi per scegliere i termini più adatti), proviamo a fare un'analisi basilare del testo.
L'aramaico è una lingua semitica, parlata nella mezzaluna fertile circa mille anni prima della nascita di Cristo e adottata dagli ebrei durante la cattività babilonese, per essere poi mantenuta al rientro in Israele.
Scrive Claude Sélis:
"Certe parti dei libri biblici di quest'epoca sono redatti direttamente in aramaico (Esdra e Daniele), e divenne necessario tradurre le stesse Scritture ebraiche in aramaico: questa fu l'origine dei targum. Nel III sec. a.C. l'ebraico era relegato al rango di lingua liturgica e letteraria. Il popolo parlava l'aramaico. Questo aramaico giudeo-palestinese sarà la lingua di Gesù, degli apostoli e dei rabbini".
Ai tempi di Gesù l'aramaico era stato sostituito dal Greco, rimanendo la lingua usata dal popolo in molte zone della Palestina, particolarmente nella zona nord, fra Nazareth e Cafarnao, dove si svolse gran parte della vita di Gesù.
In questa lingua, quindi, sarebbe stata pronunciata questa preghiera.
Eccone la versione aramaica con traslitterazione a fianco:

ed ecco la traduzione accettata sino ad oggi
'abûn : Padre nostro
d-ba-ŝmaja' : (che sei) nei cieli
netqadaŝ : sia santificato
ŝmak' : il tuo nome
u' te' : venga
malkûtak' : il regno tuo
nehwe' : sia fatto
ҫebjanak' : il volere tuo
'ajkana' : come
d-ba-ŝmaja' : nei cieli
'af : anche
ba-'ar'a' : in terra
hab' : dai
lan : a noi
lahma' : il pane
d-sûnqanan : per il nostro bisogno (quotidiano)
jaumanâ : oggi
wa-ŝbûq : e perdona
lan : a noi
hawbajn : i debiti nostri
'ajkana' : come
d-'af : anche
hanan : noi
ŝbaqn : (li) perdoniamo
i-hajabajn : ai debitori nostri
w-la' : e non
ta'lan : portarci
l-nesjûna : in tentazione
'ela : ma
paҫan : liberaci
men : dal
biŝa' : male
'ame'n : amen
Il termine che ci interessa è ta'lan, che vuol dire portare.
Indipendentemente dal fatto che si voglia intendere come portare la tentazione agli uomini o portare gli uomini alla tentazione, il verbo identifica un comportamento attivo da parte di Dio, che non si limita a non intervenire, ma agisce direttamente per mettere in difficoltà l'essere umano. E la richiesta è di non farlo.
La versione in uso fino ad oggi, infatti, traduceva il "non portarci in tentazione" con "non indurci in tentazione".
Da oggi abbiamo, però, la versione "non abbandonarci alla tentazione", assolutamente incongruente con quello che sarebbe il significato, non solo letterale, ma anche semantico, del termine ta'lan.
Come ha giustificato la Chiesa Cattolica questa modifica ?
In diversi modi.
Specifichiamo che non siamo qui a disquisire sul concetto filosofico che sta dietro a questa frase, su cui sono stati scritti fiumi di parole, anche dai padri della filosofia Cattolica, che hanno portato a giustificazioni abbastanza insostenibili fuori dall'alveo gnostico.
Limitiamoci alla traduzione che, se non letterale, deve comunque mantenere intatto il concetto espresso in origine per trasmettere il messaggio e che, se invece si trova a stravolgere il concetto alla base, stravolge anche il messaggio.
4b. Evoluzione linguistica: greco
La Chiesa Cattolica ha giustificato, prima facie, la variazione sulla base di una pretesa, erronea, traduzione dal greco alla vulgata latina. Questa giustificazione ha retto bene poco, però.
Pater - Testo Greco (Mt 6, 5-15)
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.
Traslitterazione:
Pater hēmōn, ho en tois ouranois
hagiasthētō to onoma sou;
elthetō hē basileia sou;
genethetō to thelēma sou,
hōs en ouranō, kai epi tēs gēs;
ton arton hēmōn ton epiousion dos hēmin sēmeron;
kai aphes hēmin ta opheilēmata hēmōn,
hōs kai hēmeis aphiemen tois opheiletais hēmōn;
kai mē eisenenkēs hēmas eis peirasmon,
alla rhusai hēmas apo tou ponērou.
[Hoti sou estin hē basileia, kai hē dynamis, kai hē doxa eis tous aiōnas;]
Amēn.
Il termine che qui interessa è εἰσενέγκῃς ovvero εἰσφέρῃς, cioè eisenenkēs, che in italiano possiamo tradurre con un generico "portare dentro", inteso come trascinare e, quindi, indurre.
Ovviamente la giustificazione data dalla Chiesa era insostenibile perché il Greco, in Italia, è lingua scolastica e ci si è messo poco a far notare che la traduzione dal greco alla vulgata latina era corretta.
4c. Evoluzione linguistica: latino
Traduzione latina (Vulgata)
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.
Una prima modificazione, sempre della medesima parte oggi interessata, della versione latina originale si era già avuta con la trasformazione della costruzione verbale da et ne nos inducas in tentationem a et ne inducas nos in tentationem, senza grossi problemi gnoseologici, trattandosi di una semplice scelta stilistica, che ne manteneva il significato originale. Tanto più che entrambe le scelte erano errate in quanto l'uso classico avrebbe imposto, per l'imperativo negativo la forma ne + congiuntivo perfetto da cui si sarebbe avuta la versione corretta: ne nos induxeris in tentationem. La Vulgata sceglie di usare il congiuntivo presente secondo il gusto postclassico.
4d. Evoluzione linguistica: italiano
La traduzione italiana dal latino è però quasi quella che tutti abbiamo imparato a conoscere:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane transustanziale,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen
Quasi.
Perchè appare, in questa versione, una termine supersubstantialem, che è a noi sconosciuto, ma che si avvicina ad un altro termine che tutti abbiamo imparato a conoscere (o, almeno, chi ha fatto il catechismo per la Prima Comunione): transustanziale.
5. La Transustanziazione

La Transustanziazione è un altro dogma cristiano da cui sono derivate eresie a guerre.Il termine nasce nel medioevo e viene documentato, per la prima volta, negli atti del Concilio lateranense IV, del 1215, nella professione di fede contro gli Albigesi, un'eresia gnostica oggetto della crociata in terra di Francia, nella regione della Linguadoca, voluta da papa Innocenzo III, dal 1209 al 1229, fonte di massacri esecrabili. Sempre alla lotta contro questa eresia si deve la nascita del Tribunale dell'Inquisizione, divenuto famoso nei secoli successivi per la sua opera repressiva.
Secondo questo dogma Gesù viene assunto nell'ostia dell'Eucaristia per transustanziazione, che sarebbe il cambiamento della sostanza del pane e del vino dei suoi corpo e sangue. Tale cambiamento, quasi come un'azione magica, avviene a causa delle formule pronunciate durante la consacrazione delle offerte, successivamente alla quale non si tratta più di pane e vino, ma solo della loro immagine, che ha un contenuto ben diverso e più sacro.
Questo dogma origina da un concetto trattato da San Pascasio Radberto, un monaco e abate benedettino, scrittore e teologo, vissuto dal 792 all'856 d. C., che, nel trattato De Corpore et Sanguine Domini dell'844, afferma l'identità del corpo storico di Cristo e di quello eucaristico, concezione criticata dal filosofo e teologo, Ratramno di Corbie, anche egli monaco benedettino, della medesima abbazia di Corbie nella quale visse e operò San Pascasio, vissuto dall'800 all'868, che la giudicò eccessiva aderendo, invece, alla versione maggioritaria del tempo che voleva l'identità solo simbolica, ma non per questo meno importante.
Successivamente Berengario di Tours, direttore della scuola di Chartres dal 1029, ebbe uno scontro dialettico con Lanfranco di Canterbury o di Pavia il quale, quale rettore della scuola dell'Abbazia di Bec, riteneva che l'ostia si trasformasse realmente nel corpo di Cristo. Questo scontro si trascinò per anni e fu al centro dei sinodi di Vercelli nel 1050, di Tours del 1055 e di Roma del 1059. Berengario negò il concetto stesso di transustanziazione. La controversia teologica si trascinò per anni, fino ad arrivare a San Tommaso d'Aquino che, nella sua Summa Theologica del 1265, esprime in maniera chiara il proprio pensiero, giungendo a codificare la Transustanziazione come la intendiamo oggi. Bisognerà, però, attendere il Concilio di Trento del 1545 per vedere fissato il Dogma della Transustanziazione in risposta alle dottrine riformistiche, nella sessione XIII – Decreto sull'Eucaristia.
Il pane di cui si parla nel padre nostro è, pertanto, quel pane supersustanziale, cioè dotato di una sostanza superiore, perché divina, che solo Dio può far divenire tale.
La trasformazione da supersubstantialem a cotidianum porta fuori dall'alveo liturgico e religioso il dono divino, rimettendolo nel contesto della vita di tutti i giorni e identificando la preghiera come una richiesta di aiuto concreto, per il superamento di uno dei problemi maggiori che la gente comune si trovava ad avere nell'antichità: il reperimento del cibo per sopravvivere.
Diviene quindi:
...
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
...
cioè:
...
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori;
…
Seguendo la genesi storica della vicenda linguistica del Padre Nostro, quindi, non si trovano errori di sorta, né nella sua trasformazione dall'Aramaico al Greco, né in quella dal Greco al Latino e neppure in quella finale che porta all'Italiano.
Eppure la Chiesa Cattolica ha sentito il bisogno di voler portare una modifica ingiustificata, cercando di dare giustificazioni insostenibili e, quindi, esponendosi a critiche. Se lo ha fatto, non lo ha fatto certamente per motivi futili, altrimenti non ne sarebbe valsa la pena.
Occorre, quindi, valutare cosa comporta la versione originale e cosa comporta la versione oggi adottata.
6. La tentazione

La principale differenza, come visto, sta nella provenienza della tentazione.
Si è cercato di dare una spiegazione partendo dal significato di tentazione, ma non ci pare sia necessario perdersi più di tanto nel cercare di interpretare un concetto che è chiaramente spiegato nelle stesse sacre scritture: Cristo stesso venne tentato da Satana, ed Eva dal Serpente. Eva cedette al Serpente, e Cristo non cedette a Satana. Per cui la tentazione è un qualcosa che ti porta fuori dalla retta via, che ti convince a non seguire gli insegnamenti di Dio.
La tentazione è corruzione del disegno divino, che è l'uomo, il quale non segue più la strada tracciata, ma usa per proprio interesse personale i doni divini.
Questa tentazione viene da Satana ma, se viene da Satana, come fa ad essere indotta da Dio ?
O Dio e Satana sono la medesima persona, oppure Satana è qualcosa di differente ma promanante da Dio, che quindi induce in tentazione per interposta persona.
In entrambi i casi il risultato finale è che la creazione di Satana, cioè il male, promana anche esso da Dio, come il bene.
Poco conta, in questa nostra analisi se vi sia identità fra Dio e Satana o se si tratti semplicemente di una promanazione mediata, in quanto Satana sarebbe, comunque una creazione di Dio, atto a cercare di corrompere gli uomini, sfruttando il libero arbitrio loro concesso, per portarli dalla propria parte.
Alla fine la tentazione proviene, direttamente o meno, da Dio, che può anche decidere di non operare in tal senso, lasciando, quindi, l'uomo davanti alla sola strada del bene, ma privandolo del libero arbitrio, in quanto non ci sono altre possibilità di scelta.
In questo senso la tentazione diviene la massima espressione di libertà e l'esercizio divino di quel dono che ha deciso di dare all'uomo, il libero arbitrio.
Dio da una strada, né buona né cattiva, e la corruzione della tentazione, se seguita, la rende malvagia, facendo ricadere la responsabilità della scelta e le conseguenze successive solo sull'uomo.
Oppure Dio da una strada buona, ma pone davanti all'uomo un altra possibilità per lasciargli la libertà di scelta. Quella possibilità, essendo diversa dalla strada tracciata, che è quella buona, sarà per forza sbagliata e, quindi malvagia. Per tale motivo, alla fine, comunque la scelta ricadrà sull'uomo, dotato di libero arbitrio, che potrà scegliere di non seguire la strada tracciata da Dio ma di seguirne una diversa, ma pagandone le conseguenze.
Se, invece, consideriamo come corretto il concetto di abbandonare alla tentazione, dobbiamo accettare che la tentazione sia esterna e non sia evitabile dall'uomo se non per intervento divino.
Questo crea, però, una congerie di problemi: per poter traviare la strada divina deve essere almeno altrettanto potente e, se non promana direttamente da Dio, allora deve esserci un'altra entità di uguale potere. Quindi viene meno l'unitarietà di Dio.
Se l'uomo non si può salvare se non per intervento divino, non esiste più libero arbitrio, ma solo la scelta di Dio su chi salvare o meno.
Ecco un primo concetto: occorre affidarsi a Dio per essere salvati, altrimenti non esiste salvezza. Un concetto prettamente medievale, che ha suscitato scontri teologici importanti in termini di libero arbitrio e di possibilità di scelta, con la conseguente responsabilità diretta o meno dell'uomo che sbaglia non per propria scelta o volontà, ma per il mancato intervento di Dio.
In questo senso non sarebbe più responsabile l'uomo che, se fosse condannato alla dannazione, lo sarebbe solo perché Dio ha deciso così, non per propria scelta. E la decisione di Dio sarebbe, probabilmente, dettata solo per la rinuncia dell'uomo alla propria libertà di scelta e il conformarsi assolutamente alle regole divine.
Andiamo però anche oltre: se Dio tenta, allora non siamo certi che ciò che lui ha dichiarato sia positivo. Potrebbe trattarsi di una "tentazione", perché la provenienza non è più certezza di positività del concetto.
Questo comporta problemi non indifferenti in materia di potere papale e supremazia della Chiesa Cattolica.
Chiariamo alcuni concetti, partendo dal dogma dell'Infallibilità Papale.
7a. Infallibilità papale: Concilio Vaticano I
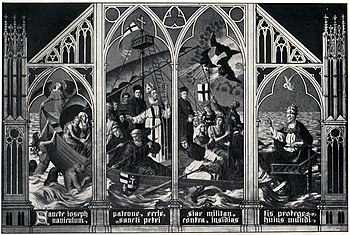
L'8 dicembre 1869 Pio IX apriva, a Roma, il Concilio Vaticano I che, stabilì il dogma dell'Infallibilità Papale, volto a rafforzare il potere del Papa.
Dopo pochi mesi l'esercito italiano fece quello che non aveva fatto pochi anni prima, prendendo Roma e facendo crollare lo Stato della Chiesa, con una strano tempismo.
Nella realtà il dogma aveva i suoi fondamenti in un concetto che era, da sempre, considerato come ovvio, identificando, la Chiesa Cattolica, il Papa come rappresentante di Dio in terra.
Solo che, col passare del tempo, questo concetto era stato più volte avversato e la nascita del Regno d'Italia aveva dato l'ultimo colpo al potere secolare del Papa e alla sua forza di ingerenza negli affari politici dei vari Stati.
Come reazione agli avvenimenti italiani il Papa decise la convocazione del Concilio che iniziò con enormi pressioni e una instabilità politica che ne metteva a rischio l'intero svolgimento. Si affrettò a stabilire il Dogma dell'Infallibilità Papale e venne sospeso per lo scoppio della guerra fra Francia e Prussia, e definitivamente interrotto per l'ingresso a Roma delle truppe Regie che posero fine allo Stato Pontificio. Verrà chiuso da Giovani XXIII quasi cento anni dopo, nel 1960, alla vigilia dell'inaugurazione del Concilio Vaticano II.
Le ragioni alla base della convocazione del Concilio erano ben chiare: nei vent'anni precedenti lo Stato Pontificio era entrato in aperto contrasto e poi conflitto, con il Piemonte prima e con lo Stato Italiano poi, per via delle leggi che riconoscevano la laicità dello stato ed espropriavano i beni ecclersiastici.
Per i Cattolici Pio IX divenne il Papa perseguitato, e il consenso che raggiunse fra le fila cattoliche lo convinse a convocare un Concilio allo scopo di confermare la superiorità delle verità di fede contro il razionalismo e il liberalismo.
Il consenso raccolto inizialmente dall'annuncio del nuovo Concilio ebbe, però, un duro colpo allorchè un articolo del periodico Civiltà Cattolica espose lo scopo reale del Concilio: far divenire l'Infallibilità del papa un dogma, ponendo il Papa stesso al di fuori e al di sopra della Chiesa.
Un dogma di questo tipo si presentava, però, come un problema a livello internazionale, destabilizzando tutti i poteri costituiti. Il Concilio divenne, quindi, un problema politico perché, oltre ad esporre i regnanti agli strali papali, metteva in ambasce anche i governi, che avevano al proprio interno una struttura parallela, spesso riconosciuta come statale, che rispondeva direttamente al capo di uno stato diverso, il quale si considerava al di sopra di ogni regola e potere terreno. Il timore era che questo potesse diventare una minaccia per l'autonomia e l'indipendenza dei diversi stati.
Venne anche proposta una Conferenza Internazionale allo scopo di studiare una linea di condotta comune per contrastare questi effetti. Alla fine si decise di attendere per vedere cosa sarebbe realmente accaduto, ma la convocazione del Concilio e il suo scopo portarono, inevitabilmente, ad un isolamento dello Stato della Chiesa e del Cattolicesimo.
Lo scontro fra correnti all'interno del Concilio si risolse con la vittoria di quella che voleva l'approvazione del dogma che, facendo leva sul timore per l'anticlericalismo e la laicità, riuscì a giungere al risultato voluto: il 18 luglio 1870, venne approvata la costituzione dogmatica Pastor Aeternus, che affermava infallibili «per se stesse e non per il consenso della Chiesa» le definizioni in materia «di fede e di costumi» proclamate dal Papa quando «parla ex cathedra». L'apprevazione avvenne sotto i più nefasti presagi, essendo in corso, durante la stessa, come raccontano le cronache, un temporale di dimensioni apocalittiche, che oscurò a lungo il cielo sopra al Vaticano.
Prima della votazione i circa 60 vescovi contrari all'approvazione del Dogma abbandonarono l'aula e dei 535 vescovi presenti solo due votarono contro.
Il giorno successivo Francia e Prussia e il Concilio venne sospeso perché molti vescovi lasciarono Roma, dopo aver emesso solo due documenti, il secondo dei quali approvato in fretta il giorno precedente allo scoppio della guerra e, quindi, alla sospensione.
Fra i sessanta vescovi contrari si trovavano molte figure importanti, ma quasi tutti si adeguarono alle decisioni conciliari. Solo una sparuta minoranza in Svizzera e Germania, guidata da Ignaz von Döllinger, il maggior oppositore al nuovo dogma, diede vita ad un gruppo scismatico.
Sul piano politico le risultanze conciliari furono, invece, un vero disastro per la Chiesa: L'Austria-Ungheria e la Baviera impugnarono ed estinsero i concordati; la Svizzera espulse alcuni vescovi; il primo ministro inglese Gladstone affermò che la Chiesa di Roma era divenuta una minaccia per lo Stato; in Germania Bismarck si allineò alla tesi inglesi ed emanò rigide leggi antiecclesiastiche.
Con strano tempismo il 20 settembre 1870 i Bersaglieri entravano in Roma, estinguendo lo Stato Pontificio e lasciando al Pontefice il solo territorio interno alle mura vaticane.
Il risultato di questo avvenimento, se fu disastroso dal punto di vista secolare, salvò la Chiesa temporale dandole una forza che non aveva previsto di poter avere.
Rendendola, infatti, prova di territorio, ma indipendente dal potere politico e avulsa dagli scontri territoriali, la rendeva superiore alle parti, transnazionale e ingiudicabile dai poteri politici.
Il dogma è chiaramente identificato negli atti conciliari:
"Perciò Noi, mantenendoci fedeli alla tradizione ricevuta dai primordi della fede cristiana, per la gloria di Dio nostro Salvatore, per l'esaltazione della religione Cattolica e per la salvezza dei popoli cristiani, con l'approvazione del sacro Concilio proclamiamo e definiamo dogma rivelato da Dio che il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, e in forza del suo supremo potere Apostolico definisce una dottrina circa la fede e i costumi, vincola tutta la Chiesa, per la divina assistenza a lui promessa nella persona del beato Pietro, gode di quell'infallibilità con cui il divino Redentore volle fosse corredata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e ai costumi: pertanto tali definizioni del Romano Pontefice sono immutabili per se stesse, e non per il consenso della Chiesa. Se qualcuno quindi avrà la presunzione di opporsi a questa Nostra definizione, Dio non voglia!: sia anatema."
(Pastor Aeternus, 18 luglio 1870)
Secondo la costituzione dogmatica, quindi, nel momento in cui il papa parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, e definisce una dottrina circa la fede e i costumi, allora vincola tutta la Chiesa in forza della divina assistenza a lui promessa.
Non che vada interpretato quanto scritto ma, volendo:
il Papa non può sbagliare, se parla di fede o di comportamenti, perché imbeccato da Dio. E Dio non sbaglia.
A questo punto il problema è identificare cosa sia sbagliare.
In un concetto dualistico di male e bene, se il bene e giusto e il male è sbagliato, il Papa non può provocare il Male perché le sue idee sono suggerite dallo stesso Dio e, essendo che Dio non può suggerire il male, quindi non può tentare (!!!), le sue idee sono, per forza, giuste.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, infatti, afferma:
...
Il grado più alto nella partecipazione all'autorità di Cristo è assicurato dal carisma dell'infallibilità. Essa si estende tanto quanto il deposito della divina Rivelazione; essa si estende anche a tutti gli elementi di dottrina, ivi compresa la morale.
... (CCC 2035)
Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la Verità, ha voluto rendere la sua chiesa partecipe della propria infallibilità.
…
Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale.
… (CCC 889-891)
7b. Infallibilità papale: effetti
Non che vada interpretato quanto scritto ma, volendo:
il Papa non può sbagliare, se parla di fede o di comportamenti, perché imbeccato da Dio. E Dio non sbaglia.
A questo punto il problema è identificare cosa sia sbagliare.
In un concetto dualistico di male e bene, se il bene e giusto e il male è sbagliato, il Papa non può provocare il Male perché le sue idee sono suggerite dallo stesso Dio e, essendo che Dio non può suggerire il male, quindi non può tentare (!!!), le sue idee sono, per forza, giuste.
Ma se Dio può tentare ?
Crolla tutto il dogma.
Conseguenze?
Sotto gli occhi di tutti: le ingerenze nel pensiero e nelle azioni dei cattolici si riverberano nella politica degli stati. In Italia gli esempi più eclatanti sono state le pronunzie contro aborto, eutanasia, omosessualità, unioni civili, divorzio, case chiuse, Partito Comunista e simili.
Come possiamo vedere tutti i giorni, queste pronunce sui costumi, che rientrano all'interno del potere assoluto pontificio, sono vincolanti per i Cristiani e provocano contrasti politici all'interno dello stato per ingerenze esterne. E le motivazioni per cui le direttive sono poste dal Pontefice non possono essere contestate da nessun Cattolico, pena la violazione del dogma dell'infallibilità papale.
Ma se invece di attaccare le pronunce del Papa, si attaccasse il dogma stesso, saremmo di fronte ad una semplice contesa filosofica all'interno della Chiesa Cattolica.
Venendo meno il dogma, allora crollerebbe tutto e il papa potrebbe vedere contrastate le sue direttive senza poter eccepire nulla: Si aprirebbero dei semplici dibattiti sui concetti all'interno della stessa Chiesa Cattolica, senza per questo venir meno ai principi della stessa.
Ma si potrebbe anche giungere al punto di vedere un pontefice finire in minoranza su qualche concetto ed essere costretto a rivedere posizioni che oggi sono assolute.
7c. Infallibilità papale: Concilio di Basilea

Questo problema fu alla base dei problemi che bersagliarono la Chiesa di Roma nel corso del XV secolo.
Il Concilio di Basilea, tenutosi nella città Svizzera dal 1431 al 1449, aveva sancito la subordinazione della volontà papale alle decisioni conciliari.
Il Concilio era stato convocato da Martino V (Oddone Colonna), nel 1431 con gli scopi di riunire la Chiesa Romana a quella Ortodossa, combattere l'eresia Hussita e riformare la Chiesa.
Con riferimento all'eresia Hussita, si trattava del movimento rispondente alle idee del teologo boemo Jan Hus, arso sul rogo nel 1415, si tratta di un argomento importante per questa nostra analisi.
Jan Hus, Professore presso l'Università di Praga, assunse posizioni molto critiche nei confronti del potere ecclesiastico e dell'infallibilità papale. Si trattava di posizioni molti simili a quelle del teologo britannico John Wyclif e dei Valdesi, i seguaci di Valdo. Nello specifico le idee Valdesi avevano un certo richiamo al Bogomilismo, una branca del cristianesimo sviluppatasi nell'est europeo attorno agli ultimi secoli del primo millennio e giunta in Europa attraverso le migrazioni delle popolazioni slave, radicandosi nelle eresie gnostiche, come quella Catara, quella Valdese e altre simili. Facile che le teorie di Hus, in parte richiemantesi a dottrine slave, fossero facilmente comprensibili e accettate dalla popolazione Boema, dove stava diffondendosi il nazionalismo slavo e dove un terzo dei terreni era in mano alla Chiesa.
Nel corso del Concilio di Costanza, convocato dell'antipapa Giovanni XXIII (Baldassarre Cossa) nel 1414 e presieduto da Re Sigismondo, Hus venne condannato a morte e arso sul rogo il 6 luglio 1415. Risultato di quanto avvenuto fu la trasformazione del movimento hussita da filosofico ad insurrezionale e la sua divisione in correnti:
• i Calixini, moderati e formati da nobili e borghesi;
• i Taboriti, estremisti che si radunarono sul monte Tabor, nella Boemia meridionale, formati in maggior parte da fasce povere e contadini, da cui originarono, successivamente, anche gli Horebiti guidati dal nobile Jan Zizka;
• gli Adamiti o Piccardi, guidati da Martin Huska.
Quando il Re di Boemia, Venceslao IV, decise di escludere gli hussiti dalle cariche pubbliche e religiose, si ebbe una vera e propria rivolta che, il 30 luglio 1419, portò alla Prima Defenestrazione di Praga ad opera di un gruppo di Taboriti guidati da Zizka, i quali uccisero, gettandoli dalle finestre, sette magistrati del Consiglio Comunale di Praga.
Questo fu l'avvenimento scatenante delle Guerre Hussite, che si trascinarono sino al 1436.
Nel 1420 vennero stilati i Quattro Articoli di Praga:
1. Libertà per i preti e per i laici di predicare le Sacre Scritture in lingua locale.
2. Comunione eucaristica sotto ambedue le forme, il calice contenente il vino e il pane, data sia agli adulti che ai bambini (il calice divenne il simbolo degli hussiti).
3. Espropriazione dei beni ecclesiastici, povertà del clero e rinuncia ai beni materiali.
4. Pene esemplari per i peccati mortali commessi da membri del clero.
Il Concilio di Basilea venne aperto dal successore di Martino V, Eugenio VI (Gabriele Condulmer), il 24 luglio 1431. Questi aveva promesso al Conclave da cui era stato eletto la propria sottomissione al Sacro Collegio il quale, nel clima di scontro fra Cardinali e Vescovi per il controllo della Chiesa, voleva prendere il controllo del prossimo Concilio.
Eugenio, tutt'altro che propenso a farsi controllare dai Cardinali e ben sapendo quanto il Concilio fosse deciso a far valere la propria superiorità rispetto a quella Papale, essendo fautore del Primato Pontificio, nel 1438 fece spostare il concilio da Basilea a Ferrara.
Dopo aver ricomposto la questione Boema, su pressione del re Sigismondo, divenuto Imperatore nel 1433, i conciliaristi avrebbero dovuto affrontare la questione del primato ideologico all'interno della Chiesa. Lo spostamento del concilio da Basilea a Ferrara provocò uno scisma. Circa 300 membri minori, oltre ad un Cardinale e alcuni dottori, rimasero a Basilea e, con l'appoggio delle Università, dichiararono decaduto il Papa, eleggendo in sua vece un antipapa nella figura di Amedeo VIII di Savoia, col nome di Felice V.
A Ferrara intanto giunse, per trattare la riunione delle chiese Cattolica e Ortodossa, una delegazione di 700 bizantini, guidati dall'imperatore Giovanni VIII Paleologo, della quale facevano parte suo fratello Demetrio, il patriarca di Costantinopoli Giuseppe II e un numero imprecisato di vescovi, dotti e teologi, tra i quali spiccavano Basilio Bessarione, Isidoro di Kiev, Marco Efesio, Balsamon, Giorgio Gemisto Pletone, Giorgio Scolario e Giovanni Argiropulo.
Nel 1439, però, la peste giunse a Ferrara e i conciliaristi se ne andarono, trasferendosi a Firenze.
Fra i vari punti trattati allo scopo di riunire le due chiese, vi fu anche quello del Primato Papale.
Su tutti i punti si giunse ad un sostanziale accordo e il 6 luglio 1439 venne emesso il decreto Laetentur coeli che prevedeva la completa riunificazione. A documenti simili si giunse anche con i siri, i copti e gli armeni.
Al ritorno a Costantinopoli, però, i risultati del concilio non vennero ratificati 21 dei 31 vescovi e dignitari firmatari ritrattarono quanto concordato e negarono l'accordo, soprattutto a causa del rifiuto delle comunità bizantine di sottoporsi al potere papale.
Come vediamo, quindi, il problema del Primato Assoluto del Papa era ben compreso anche nei tempi antichi, e le sue conseguenze tali da portare a scontri e guerre, scismi e fratture interne.
Ecco, perché, quindi, il cercare di far passare sotto traccia quanto avvenuto in ordine a quella semplice parola del Pater Noster diventa ancor più sospetto.
8. Conclusioni

Alla fine di tutto si può trarre una sola conclusione: il Padre Nostro ha una valenza particolare per la dottrina cristiana e un dogma in contrasto con il suo contenuto sarebbe insostenibile. Ecco che, quindi, se si vuole dare al Papa il potere di decidere per tutti i cattolici in modo da non poter essere contrastato da nessuno, occorre rimuovere quella parte del Padre Nostro che darebbe la possibilità di mettere in dubbio il dogma dell'Infallibilità Papale. In assenza di quella parte, nessuno più potrebbe impedire al Papa di comandare, secondo la propria semplice volontà, su un miliardo e quattrocento milioni di persone. Il terzo stato al mondo per popolazione, ma con delle prerogative e caratteristiche peculiari, come quella di poter indirizzare la politica di numerosi stati sovrani.
Ad oggi nessuna delle giustificazioni tecniche addotte dalla Santa Sede trova fondamento, men che mai quelle filosofiche e risultano risibili i tentativi di sminuire quanto avvenuto.
Siamo di fronte ad un nuovo medioevo concettuale in seno alla Chiesa, che si voleva, invece, pronta ad aperture e rinnovamenti che l'avrebbero portata nel terzo millennio.
Che questo avvenga ad opera del primo Papa gesuita della storia è anche ovvio. I Gesuiti hanno fatto dell'obbedienza al Papa il proprio principio fondamentale, tanto da essere stati soppressi nel XVI secolo a causa dei contrasti che il loro operato, in aperto conflitto con gli stati che li ospitavano, aveva provocato in Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera, Francia, Polonia, Svezia e via via in tutti gli altri stati europei, compreso lo Stato Pontificio, tranne che in Russia.
Erano visti come il braccio secolare del Papa e considerati pericolosi per la stabilità interna degli stati, questo per la loro assoluta obbedienza agli ordini papali.
Solo nel 1814 Papa Pio VII ripristinò la Compagnia di Gesù.
Lo scopo dei gesuiti divenne, dopo questa loro rinascita, quello di difendere la Santa Sede dal laicismo e liberalismo emergente, favorendo l'accentramento delle strutture ecclesiastiche. Tutte queste attività culminarono nel concilio Vaticano I e nella proclamazione del dogma dell'infallibilità papale.
Il loro operato intransigente, nel corso del XIX secolo, li portò nuovamente a scontrarsi con gli stati che li ospitavano, da cui scaturì per loro l'espulsione dalla Russia, dalla Spagna, dal regno di Napoli, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Svizzera e dalla Germania.
In Italia furono accusati di essere uno dei principali ostacoli alla realizzazione dell'unità nazionale.
In questo contesto le modifiche al Padre Nostro si pongono nel più grande disegno Gesuita di rendere inattaccabile il Dogma dell'Infallibilità Papale e riportare la Chiesa Cattolica alla propria originaria rigidità dogmatica antimodernista e antiliberale, disegno che il primo Papa gesuita della storia sta portando avanti con una lucidità e un pragmatismo degni di un generale.
Bibliografia e collegamenti
- https://derash.weebly.com/le-lingue-della-bibbia.html
- https://www.leslibraires.fr/personne/claude-selis/1903547/
- https://www.gesustorico.it/htm/aramaico/pater_aramaico.asp
- https://www.liturgia.it/content/pater/pater_noster.htm
- https://it.wikipedia.org/wiki/Padre_nostro
- https://www.treccani.it/enciclopedia/transustanziazione_(Enciclopedia-Italiana)/
- https://it.cathopedia.org/wiki/Tentazione
- https://it.aleteia.org/2018/10/31/differenza-tra-prova-e-tentazione
- https://www.treccani.it/enciclopedia/tentazione_(Enciclopedia-Dantesca)/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/concilio-di-basilea_(Dizionario-di-Storia)/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/jan-hus/
- https://eresie.com/it/Hussiti.htm
- https://it.aleteia.org/2022/12/30/linfallibilita-papale-significa-che-il-papa-ha-sempre-ragione
- https://www.treccani.it/enciclopedia/gesuiti/